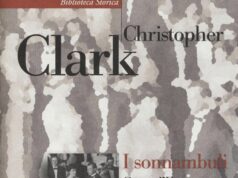Inizia con questo articolo la collaborazione con Economia&FinanzaVerde di Emanuele Sommario, Professore Associato di Diritto Internazionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Direttore del Master in Human Rights and Conflict Management. Contribuisce alla rubrica “Pillole di diritto internazionale”, linea editoriale della piattaforma, curata dalla Dottoressa Francesca Capone della stessa Scuola Superiore.
Tempo di lettura: 5’
Che fine ha fatto il conflitto in Etiopia? Mentre l’attenzione sull’Afghanistan e sulla presa di potere dei Talebani non accenna, giustamente, a diminuire, ci si potrebbe, però, legittimamente interrogare sulle motivazioni per cui la vicenda afghana è considerata d’interesse internazionale mentre il conflitto armato che sta mettendo in ginocchio l’Etiopia dal novembre 2020 viene invece bollato come una “questione interna”. Ciò anche alla lucedella clamorosa espulsione dal Paese di 7 funzionari delle Nazioni Unite, inclusi rappresentanti dell’UNICEF e dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA).
Proprio per puntare i riflettori su una situazione sempre più complessa, che si propaga a livello nazionale e fa temere spilloveroltre la frontiera, questo breve post si propone di spiegare le origini e la natura del conflitto, evidenziando alcuni dei profili di diritto internazionale rilevanti e riflettendo sul perché la guerra in Etiopia è un problema che riguarda non solo il Corno d’Africa, ma anche l’Italia e il resto del mondo.
Le origini e la natura del conflitto tra il Governo etiope ed il Fronte di Liberazione Popolare del Tigray
Come è noto l’Etiopia è un paese da sempre contrassegnato da gravi tensioni etniche, temperate sul piano istituzionale attraverso l’attuazione di un modello federale su base etnica (per un approfondimento sul costituzionalismo etiope rimando al recente volume collettaneo curato dai colleghi Giuseppe Martinicoe Giacomo Delledonne). In breve, adottando questo modello la costituzione federale etiope del 1995 non ha semplicemente riorganizzato su base regionale l’assetto del paese, ma “ha incluso nel nuovo stato le diverse nazionalità su base etnica, ridefinendo anche i contenuti della stessa cittadinanza alla luce del principio di auto-determinazione”. Le nove regioni in cui è divisa l’Etiopia sono caratterizzate dalla centralità della dimensione etnica nella rivendicazione dei diritti di accesso alla terra, al lavoro e alla rappresentanza politica delle comunità locali. L’origine del conflitto armato attualmente in atto va ricercata proprio nello scontro tra un centro di potere regionale/etnico, il Tigray (o Tigrè), situato nel nord del Paese, e il Governo centrale, guidato, a partire dal 2018, dal primo Ministro (e vincitore del Nobel per la pace nel 2019 per l’impegno profuso per porre fine al conflitto con la vicina Eritrea e la promozione di significative riforme politiche ed economiche) Abiy Ahmed Ali. Il contrasto tra la regione popolata dall’etnia tigrina (storicamente egemone in Etiopia, sebbene minoritaria) e il Governo è ufficialmente iniziato nel settembre 2020, quando il Fronte di Liberazione Popolare del Tigray (FLPT, più noto l’acronimo inglese TPLF) ha indetto autonomamente elezioni regionali, contravvenendo alle indicazioni del Governo. Questo, oltre a non riconoscere l’esito delle elezioni, ha apertamente accusato il Fronte di autoritarismo e di ostacolare il processo di integrazione nazionale intrapreso dal premier AbiyAhmed.
Il casus belli
Il casus belli però è stato l’attacco da parte delle truppe delFLPT al comando dei reparti militari federali stanziati in Tigray, che il 4 novembre 2020 ha fornito all’esercito federale etiope un motivo per attaccare la regione. Il 30 novembre il premier aveva già dichiarato conclusa l’operazione militare, portata avanti anche con il contributo dell’ “alleata” Eritrea. In realtà la guerra – perché si tratta effettivamente di un conflitto armato non-internazionale –non è ancora finita, anzi in questo momento sta attraversando una fase particolarmente drammatica. Chiaramente, come accade per ogni conflitto, a pagare le conseguenze della guerra subendo atrocità da parte di tutti gli attori convolti sono soprattutto i civili(non ci sono stime precise, perché le informazioni che trapelano sono poche e frammentarie, ma, ad oggi, si parla di più di due milioni di dispersi e più di 5 milioni di persone che necessitano assistenza urgente). Con lo scopo di “internalizzare” il più possibile il conflitto e di allontanare il rischio di ingerenze esterne, a maggio 2021 il Parlamento etiope ha designato il Fronte tigrino come organizzazione terroristica. Ha così sfruttato una prerogativa prevista che deriva da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la numero 1373 del 2001, che consente agli Stati di includere in liste nazionali (redatte in autonomia dai singoli Paesi) individui e organizzazioni terroristiche a cui applicare misure restrittive. Come avviene in tanti altri contesti e situazioni, basti citare la persecuzione di Pechino nei confronti degli Uiguri, lo spauracchio del terrorismo è notoriamente utilizzato come giustificazione, soprattutto agli occhi di interlocutori esterni, per reprimere oppositori politici, gruppi etnici minoritari o movimenti separatisti. Questa tendenza, che si fonda su un’interpretazione illegittima degli obblighi derivanti dal diritto internazionale in tema di contrasto al terrorismo, andrebbe rigettata. Peraltro, è importante ricordare che la designazione di un gruppo armato non statale come terroristico non ha alcuna implicazione dal punto di vista del diritto bellico e non esonera dall’applicazione delle norme che regolano, sempre e comunque, la condotta delle ostilità. Ad esempio, negare ai civili del Tigrayl’accesso agli aiuti umanitari, accusa che è stata mossa da più fronti al Governo etiope, rappresenta una violazione degli obblighi, consuetudinari e pattizi, sanciti dal diritto internazionale.
Il silenzio dell’Italia e della comunità internazionale
Al momento le reazioni della comunità internazionale (così come quelle del nostro Paese) sono state molto tiepide e poco incisive, confermando una tacita adesione alla strategia del premier Ahmed, che, ricordiamolo, presenta il conflitto in corso come una questione interna. A livello internazionale l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha ribadito nel corso degli ultimi mesi la gravità della situazione, sottolineando nei suoi interventi che il conflitto rischia di estendersi a regioni limitrofe e che tutte le parti in causa hanno commesso violenti abusi ai danni della popolazione civile. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l’unico organo che potrebbe prendere decisioni operative sulla questione, non si è mai pronunciato, nemmeno dopo l’allarmato appello del Segretario Generale delle NU Antonio Guterres.
In contrasto con l’inerzia collettiva, il Presidente degli Stati Uniti ha recentemente firmato un ordine esecutivo che prevede l’imposizione di sanzioni, tra cui il congelamento di capitali ed il divieto di ingresso e transito nel paese, nei confronti degli attori, statali e non, che commettono gravi violazioni dei diritti umani ai danni dei civili nell’ambito del conflitto in Etiopia. Organizzazioni non governative, come Human Rights Watch, hanno apertamente chiesto ad altri Stati e organizzazioni internazionali e regionali di fare lo stesso. E’ tuttavia chiaro che l’appello non porterà i risultati sperati, almeno per quanto riguarda l’Unione Europea e l’Italia.
Proprio in relazione all’UE e all’Italia è utile ribadire che entrambi considerano l’Etiopia un attore chiave nel Corno d’Africa, probabilmente il più rilevante e affidabile della regione. L’Unione Europea nel 2021 ha stanziato 53.7 milioni di Euro in progetti per sostenere la popolazione in Etiopia, di cui 11 milioni destinati espressamente al sostegno della popolazione tigrina. Sul piano diplomatico, però, la voce dell’UE è poco più di un sussurro a dispetto delle prese di posizione formali. L’Italia, da parte sua non sembra intenzionata a sfruttare il suo ruolo di partner ed interlocutore privilegiato. A dispetto di qualche dichiarazionefuori dal coro, come quella dell’ex Ministra della Difesa Elisabetta Trenta che ha recentemente invocato l’adozione di azioni incisive per fermare la guerra in atto, il Governo in carica non sembra intenzionato ad intraprendere questa strada. Anche nelle dichiarazioni ufficiali rese davanti al Consiglio per i Diritti Umani delle NU, il nostro paese non ha indicato responsabilità chiare, limitandosi ad invocare il rispetto del diritto bellico da parte di tutti i belligeranti.
Il rischio di “balcanizzazione” dell’Etiopia
In conclusione, tanti attori evocano il rischio di balcanizzazione dell’Etiopia, e lo spettro del genocidio di Srebrenica aleggia sul Tigray, senza però scuotere a sufficienza le coscienze. Tutti riconoscono che sono state perpetrate graviviolazioni dei diritti umani e del diritto bellico, ma nessuno, a parte forse gli Stati Uniti, spinge fino in fondo per la risoluzione del conflitto. A complicare ulteriormente le cose contribuisce l’instabilità della relazioni esterne dell’Etiopia, messe a dura prova dalla controversia con Sudan ed Egitto per la costruzione della colossale diga sul Nilo Azzurro. Nel contempo la Turchia di Erdogan si propone come nuovo partner strategico per il Governo etiope, provando anche a mediare con Khartum e Il Cairo dopo il fallimentare tentativo dell’Unione Africana. Tra nuove alleanze e presunte guerre al terrore (per definizione “giuste” e non soggette a scrutinio) l’Etiopia guidata dal Partito della Prosperità del premier Abiy Ahmed è purtroppo una polveriera che rischia di esplodere, con conseguenze assai pericolose anche oltre i confini regionali.