Le lingue cambiano.
Le lingue, per fortuna, cambiano. Il linguaggio si evolve ed è naturale che succeda, come è sempre accaduto dall’origine dei vari idiomi, ma oggi la velocità ha invaso tutti i processi e parole che erano del tutto sconosciute qualche anno fa, sono diventate, quasi d’improvviso, i vocaboli dominanti dei nostri colloqui, dei nostri scritti e dell’informazione.
Pur essendo d’accordo conl’evoluzione del linguaggio (anche se credo sia necessario mantenere un contatto con la tradizione)dobbiamo evitare di stravolgere rapidamente le costruzioni e di utilizzare le nuove parole veramente quando essere sono necessarie, altrimenti rischiamo di non capirci più.
Rispetto ad altre lingue moderne di cultura, l’evoluzione e il consolidamento della lingua italiana sono stati essenzialmente dettati dell’autorità del modello letterario e, fino alla metà nel Novecento le principali fonti di innovazione lessicale consistevano nel talento e, talvolta, nella creatività di scrittori e intellettuali.
L’evoluzione della lingua è naturale, ma oggi la velocità ha invaso tutti i processi.
Bisogna prestare attenzione a mantenere il contatto sia con la tradizione precedente, sia con la società in cui viviamo. Adesso sono i mass-media, i politici e le varie figure (influencer, blogger, youtuber, ecc.) che popolano il web i grandi produttori di neologismi (peraltro queste nuove “professioni” sono loro stessi dei neologismi): parole come webete, brexit, fake news, hashtag, ciaone, sbroccare, taggare, postare, selfie, spammare, tante per citarne alcune che mi vengono subito in mente, sconosciute fino a 10 anni fa, sono adesso presenti nei discorsi di tutti i giorni.
I social sono accusati di distruggere l’italiano. In realtà la nostra lingua, immutata per secoli, sta dimostrando ottima capacità di adattamento ai nuovi media. Sono, piuttosto, gli Italiani che da molti decenni mostrano una regressione culturale che riversano sui social senza troppa attenzione alla loro reputazione.
Una delle parole che negli ultimi mesi viene sempre più frequentemente pronunciata è sicuramente “sovranismo” per sottolineare la priorità nei confronti di tutte le persone e, aggiungo io, di cose di nazionalità diversa con la rivendicazione di una sovranità nazionale assoluta nei confronti di tuttigli organismi sovranazionali.
La cosa assume carattere ironico se si pensa che sovranismo è, nell’accezione corrente, una parola d’origine straniera. I primi a parlare di souverainisme, infatti, credo siano stati nel 1967 (almeno così ho letto) gli indipendentisti del Quebec: quella parte del Canada dove si parla francese, dopodiché la parola è stata via via adottata in contesti diversi.
Il sovranismo botanico
Parlando con un amico paesaggista che si lamentava del fatto che un’Amministrazione aveva imposto che in un progetto venissero utilizzate solo specie autoctone senza addurre alcuna motivazione tecnico-scientifica, ho sarcasticamente commentato: “Adesso abbiamo anche il sovranismo botanico!”. Ecco perché, riflettendoci un po’ su, ho pensato di scrivere qualcosa sull’argomento. Ho intitolato questa breve riflessione “sovranismo botanico” pensando alla miope e ottusa visione di certe persone e di certe amministrazioni che pretendono, spesso senza addurre alcuna logica giustificazione, che per i nuovi progetti e i successivi impianti “si utilizzino solo specie autoctone” e che vengano adottate tecniche ormai obsolete di impianto e gestione anche in questo caso senza che ciò sia realmente basato su conoscenze reali.
 La cosa strana e, se ci pensiamo poco comprensibile, è che mentre pretendiamo il top (altro neologismo) e spendiamo il massimo dalle nuove tecnologie (che a causa di una arretratezza tecnologica del nostro paese che non investe in ricerca, provengono quasi sempre dall’estero) e siamo in attesa fervida di cosa ci riserverà il prossimo futuro (pensiamo alle code che si formano per acquistare l’ultimo modello di un famoso smartphone), sembra ci sia un ritorno al passato per quanto riguarda, ad esempio, l’agricoltura e l’ambiente, settori per i quali c’è una forte ostilità per l’applicazione delle nuove tecnologie e per le novità che, invece, potrebbero non solo consentirci di affrontare meglio le sfide che il futuro ci riserverà, ma anche di produrre di più in termini quali-quantitativi.
La cosa strana e, se ci pensiamo poco comprensibile, è che mentre pretendiamo il top (altro neologismo) e spendiamo il massimo dalle nuove tecnologie (che a causa di una arretratezza tecnologica del nostro paese che non investe in ricerca, provengono quasi sempre dall’estero) e siamo in attesa fervida di cosa ci riserverà il prossimo futuro (pensiamo alle code che si formano per acquistare l’ultimo modello di un famoso smartphone), sembra ci sia un ritorno al passato per quanto riguarda, ad esempio, l’agricoltura e l’ambiente, settori per i quali c’è una forte ostilità per l’applicazione delle nuove tecnologie e per le novità che, invece, potrebbero non solo consentirci di affrontare meglio le sfide che il futuro ci riserverà, ma anche di produrre di più in termini quali-quantitativi.
In gran parte delle politiche urbane e pratiche contemporanee, le specie vegetali non native vengono presentate come di scarso valore nella migliore delle ipotesi o dannose nel peggiore dei casi. Queste posizioni alimentano una presunzione prevalente all’interno di molti pianificatori, architetti paesaggisti, ufficiali delle autorità locali e professionisti della conservazione che l’infrastruttura verde sostenibile del XXI secolo dovrebbe essere composta esclusivamente da piante native.
Esiste ora una chiara dimostrazione del fatto che l’invasività non è una proprietà fondamentale delle specie vegetali non native, ma piuttosto una caratteristica delle specie autoctone ed esotiche che possiedono determinati tratti ecologici e una crescente minoranza nell’ecologia vede l’ostilità nei confronti dei non nativi come una diversione dal vero problema del mantenimento della diversità negli ecosistemi verso cui le specie non native possono anche dare un contributo positivo.
Diversi autori hanno dimostrato che le specie di piante provenienti da areali simili, seppur lontani, sono ugualmente preziose come fonti di cibo per molti animali nativi e più in alcuni casi rispetto alle specie native.
Le piante non native possono anche fornire benefici specifici agli invertebrati nativi come l’estensione della disponibilità di polline e nettare oltre la stagione di fioritura delle specie vegetali autoctone. Un altro fattore importante nell’ostilità per ciò che non è nativo è l’idea che siano qualcosa al fuori di ciò che è “naturale”.
Questa idea è radicata nella nozione che il passato era come il presente, il che non è chiaramente vero o, perlomeno, non del tutto. Nel nostro tempo il cambiamento climatico ha già avuto un profondo impatto sulla distribuzione di specie animali e vegetali in tutto il mondo con specie che migrano verso i poli o ad altitudini più elevate con l’aumento delle temperature, con questomodellando nuovi ecosistemi.
Da dove vengono le piante
È irrealistico e poco pratico tentare il ripristino degli habitat a qualche legittimo “stato storico”composto esclusivamente da specie attualmente autoctone, perché il cambiamento climatico renderà alcune di queste (come ad es. la Betula pendula nel Sud Inghilterra) sempre meno adatte alle mutate condizioni.
All’interno dei paesaggi urbani progettati può essere quindi non solo opportuno, ma talora necessario, incorporare nuove specie con una potenziale utilità in termini di “idoneità” a un clima più caldo e con eventi estremi, ma ciò solleva questioni su ciò che è culturalmente accettabile. Le preoccupazioni biologiche circa l’invasività delle piante non indigene e la loro incompatibilità con la fauna locale sembrano essersi trasformate in alcuni casi nella convinzione che queste piante siano meno attraenti o culturalmente meno rilevanti per le persone rispetto alle piante native.
Proprio guardando al passato, appare chiaro come le piante non native siano state percepite positivamente come nuove e interessanti e ampiamente utilizzate in paesaggi e parchi fin dal Rinascimento (e in molti casi molto prima). Le piante aliene sono state importanti nella cultura europea per così tanto tempo, che la comprensione pubblica di ciò che è nativo e non-nativo è spesso diventata molto confusa.
Se questo è il caso, allora “natività” è poco più di un’idea astratta. I risultati di un ampio studio europeo suggeriscono che “nativo” non è una caratteristica visibile identificabile per il pubblico in generale, poiché è più probabile che esso emetta giudizi basati esclusivamente sull’attrattiva percepita delle specie o perché influenzato da alcune informazioni non sempre esatte.
Del resto, che dire delle specie da frutto che normalmente consumiamo? Molti pensano, avendole sempre viste sulle nostre tavole e addirittura raffigurate nei quadri di Bartolomeo Bimbi, pittore a servizio di Cosimo III de’ Medici e poi della figlia l’Elettrice Palatina Maria Luisa de’ Medici, che siano native quando, in realtà, la stragrande maggioranza di esse proviene dall’areale cinese.
Come ho avuto modo di dire più volte, salvaguardare e conservare il nostro paesaggio è fondamentale, ma non può e non deve voler dire cristallizzarlo, imponendo scelte anacronistiche che non tengono conto del cambiamento non solo storico, sociale, economico ma anche climatico e ambientale.





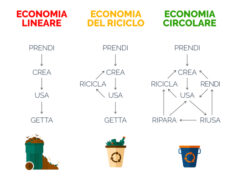
Perfettamente d’accordo con questa analisi. La tecnologia avanza in tutti i campi e l’agricoltura in generale e la botanica in particolare devono arretrare. Ho sostenuto varie discussioni sul argomento e ho sempre domandato: Dove è l’area in cui una pianta è autoctona e dove no? Prendiamo l’esempio di un faggio, bellissima pianta che tutti ammiriamo sulle nostre montagne, ma se lo piantiamo in un giardino in centro a Firenze, è ancora autoctona? E’ una pianta che vive nel suo ambiente? Non è piuttosto una pianta aliena che stenta a vivere in questo nuovo ambiente?