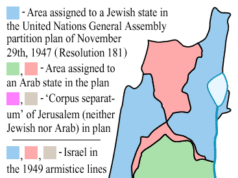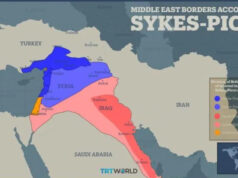Questo è la prima riflessione del sociologo Edoardo Tabasso sulla comunicazione nei nuovi scenari della rivoluzione digitale, destinata alla nostra piattaforma. Tabasso fa parte del Réseau pour l’étude des théories du complot, un centro di ricerche internazionale e interdisciplinare a cui aderiscono ricercatori e studiosi di differenti università, dedicato agli studi sulle teorie e le retoriche del complotto che hanno radici profonde nella storia. Gli obiettivi del Rèseau sono quelli di evidenziare come il rischio della disinformazione ponga al centro una costellazione di sfide scientifiche, culturali, politiche, tecnologiche, economico finanziarie e geopolitiche decisive per i destini della governance globale. Il ruolo dell’Europa sembra diventare sempre più marginale.
Tempo di lettura: sei minuti.
Prima puntata
Viviamo in uno di quei periodi storici in cui le innovazioni tecnologiche vengono vissute e raccontate come uno dei principali motori che alimentano dinamiche trasformazioni e al cui centro vi è l’uso dei media digitali. Tuttavia, forse proprio poiché il ruolo delle innovazioni tecniche appare scontato, le riflessioni più comunemente diffuse rispetto al ruolo delle nuove tecnologie sono molto spesso semplicistiche: in maniera ricorrente, ascoltiamo descrizioni e racconti che insistono su come i nuovi media producono effetti positivi e negativi sul mondo sociale e sulla vita delle persone.
Tablet, smartphone, gps, siti social network, piattaforme di condivisione, database avanzati. E con esse le audience che diventano prosumer cioè non più semplici spettatori o ma produttori e consumatori di contenuti. Una cambio di passo nei panorami mediali che coinvolge anche i vecchi media: tv cinema radio, giornali.
In questo decennio mentre il cyberspazio di Facebook e i mercati finanziari sembrano non conoscere confini, aumenta la percezione della distanza tra chi si sente incerto, insicuro e in balia del vento della globalizzazione, e chi invece sembra essere intimamente partecipe dei processi globali.
Non siamo ancora entrati nella società della conoscenza. Siamo, invece, in un’ambigua società dell’informazione, nella quale le tecnologie informatiche hanno prolungato nel tempo e reso più pervasive le tecniche della parcellizzazione del lavoro, delle conoscenze e delle competenze.
Ma non solo. La democrazia tende a creare creduloni, per citare Jerome Bronner per via della sua liberalizzazione incontrollata . E sta diventando sempre più evidente che l’informazione – e cioè l’insieme di tutti i contenuti che i media di comunicazione producono e fanno circolare attraverso il mondo – è fuori controllo. Fuori dal controllo dei governi, ma anche fuori dal controllo di uno qualsiasi degli altri poteri effettivi.
Se la velocità della circolazione di informazioni e della comunicazione sembrano proiettarci in avanti, l’insicurezza incentiva ritorni integralisti, velleità restauratrici e determinismo tecnologico in nome del quale le sole tecnologie sarebbero la determinante principale di una serie di cambiamenti rilevanti.
La Rete ha spostato, confuso, mascherato, non smascherato, attraverso i social gli equilibri di potere. Ma non è questo che la comunicazione nelle sue innovazioni tecnologiche sociali e economiche provoca almeno dal 1500 quando la rivoluzione della stampa ha indotto cambiamenti epocali uno dopo l’altro? Per ora possiamo solo constatare che la Rete e i social hanno accentuato le radicalizzazioni delle opinioni e dei pregiudizi.

Seconda Puntata
La disinformazione distorta e da spazzatura non è nata con Internet e tanto meno con i social media. Tutto è cominciato con i giornali, o ancora prima, e si è ingigantito con la radio e la televisione, per diventare capillare con le piattaforme sociali digitali.
Se da un lato gli effetti benefici di Internet sono noti, anche se guidati da una dinamica ancora poco chiara, quelli ambigui sono meno visibili, ma non per questo meno virali e dirompenti.
Invece di riflettere, si conia il termine fake news per indicare notizie contraffatte, artefatte, costruite. In altre parole, si diventa cospirazionisti: invece di capire qual è il problema, si individua un colpevole generico, un capro espiatorio di volta in volta.
Ci si appella a fantomatici algoritmi per ripulire il mondo dal falso, dimenticandoci che la matematica ha già dimostrato fragilità nel compito di individuare le bugie, per la struttura stessa del nuovo spazio in cui si muovono le notizie. Uno spazio dove le distanze sono annullate, i tempi sono schiacciati, la riflessione scompare. Dove le notizie che confermano quello che già si crede di sapere sono molto ascoltate. Quelle che non confermano le nostre credenze sono ignorate.
I media group digitali non congiurano per alzare i prezzi. Non ci vendono gli scarti, ma servizi sofisticati e utili. E prosperano sulle informazioni, le nostre, che ogni giorno gli regaliamo, spesso inconsapevoli. Oggi la Rete e i protagonisti che la animano sono sempre più spesso associati a fenomeni di disinformazione, hate speech e propaganda che aprono le porte a nuovi tribalismi.
Il rischio globale della disinformazione digitale si pone al centro di una costellazione di rischi tecnologici e geopolitici che vanno dal terrorismo ai cyberattacchi, al fallimento della governance globale.
La crescente percezione della mole immensa di dati che le web e le software company raccolgono, manipolano, rivendono, configura il più imponente sistema di controllo delle informazioni mai concepito.
Tutto questo ha acquisto un peso enorme nell’economia finanziaria globale. Mediobanca ha pubblicato un’analisi sulle Software and Web Companies: 21 gruppi dei quali 14 hanno sede negli USA, 5 in Cina, 1 in Giappone e 1 in Europa. La top ten, che per anni è stata prerogativa dei colossi USA come Google, Microsoft, Amazon e Facebook, ora è condivisa con i concorrenti cinesi come Alibaba.
 In cinque anni, tra il 2012 e il 2016, attraverso l’utilizzo dei paradisi fiscali i giganti del software e del web hanno eluso 46 miliardi di euro, che diventano 69 se si aggiunge Apple che genera la maggior parte del fatturato hardware. Crescono, macinano fatturato, hanno utili mostruosi: 2.781 mld di euro, oltre sei volte il valore della Borsa Italiana (la sola Apple vale più della Borsa italiana) e quasi quanto il Pil della Germania.
In cinque anni, tra il 2012 e il 2016, attraverso l’utilizzo dei paradisi fiscali i giganti del software e del web hanno eluso 46 miliardi di euro, che diventano 69 se si aggiunge Apple che genera la maggior parte del fatturato hardware. Crescono, macinano fatturato, hanno utili mostruosi: 2.781 mld di euro, oltre sei volte il valore della Borsa Italiana (la sola Apple vale più della Borsa italiana) e quasi quanto il Pil della Germania.
Hanno segnato nel 2016 vendite per 558 miliardi di euro e utili per 86,5 miliardi. Realizzano il 4.3% del fatturato globale delle multinazionali prese in esame e hanno solo il 3.8% dei dipendenti.
L’Europa è completamente fuori dai giochi. Solo la Germania ha un’azienda, la Sap, che può dire la sua nello scenario geopolitico del software.
In mezzo… c’è un problemino di democrazia economica. Chi ha comprato le azioni non ha alcun diritto di voto in assemblea, molte delle le società restano saldamente in mano ai fondatori, nonostante posseggano quote minoritarie del capitale.
Un disegno di legge con sostegno bipartisan presentato al Senato americano prevede che tutte le piattaforme digitali che hanno almeno 50 milioni di visite o di utenti siano tenute a conservare in un archivio di pubblico dominio tutti gli annunci pubblicitari di carattere politico, includendo l’identità dell’inserzionista. Quando chi trasmette uno spot politico in radio, in tv o su un giornale è già obbligato a rivelare per quale gruppo lavora e quale candidato sostiene.
Amazon, Apple, Google, Facebook and Microsoft hanno investito più di 13 milioni di dollari negli ultimi tre mesi in azioni di lobby per fare pressione su rappresentanti del Congresso sulla pubblicità online, sui contenuti in Internet, sull’antitrust e perfino sull’immigrazione
Se i governi vogliono agire, alcune misure sono necessarie, evitando però mosse azzardate. Perché, come qualcuno ha fatto notare, essere monopolizzati da cinque compagnie americane è sempre meglio che esserlo da 3 cinesi. Piuttosto, per rompere il monopolio senza danneggiare l’innovazione il modo migliore è introdurre nuovi elementi di competizione e favorire la concorrenza: uniche ricette efficaci per combattere gli abusi e provare a smascherare le bugie che corrono sui social.